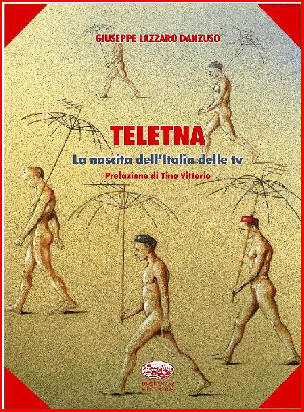
“Per il luogo dove sono nato
provo
una ripugnanza che arriva al
disgusto fisico[…].
Tutto quanto è vile e comune nel
genere borghese
mi ricorda Grenoble; tutto quanto mi ricorda
Grenoble
mi fa orrore,
no, orrore è troppo nobile; mi nausea” ( Henri Beyle)
Pippo
Sapienza, in arte Pernacchia, Pippo
Fava e, nel mezzo, Teletna di un
altro Pippo, Pippo Recca: così vengono raccontati nel saggio, Teletna, nascita dell'Italia delle TV, (Bonanno 2009) di Giuseppe Lazzaro Danzuso gli anni Settanta del secolo scorso a Catania.
Non
ci capivamo niente, noi stendhaliani di provincia (ma tutti i lettori di Stendhal erano provinciali,
dannatamente marginali, e Stendhal odiava la città natale, Grenoble, come si
può odiare una prigione di mediocrità e di ottusa violenza).
Non
ci capivamo niente e si vuole dire che ci era tutto chiaro: Manlio Sgalambro
avrebbe detto (di Catania) che “nella città si può cogliere il tramonto di una
civiltà camminando per le sue vie e dal volto dei suoi abitanti si può scoprire
quanto sono vicini i barbari”.
Si
esaltava l’antica vocazione catanese di “fabbricar palazzi”, una vocazione da
terremotati, da dissepolti dalle macerie di quei terremoti che costringono i
sopravvissuti a ricostruire come ossessi, come il frullìo di api impazzite
davanti a un alveare crepato.
Si riduceva ulteriormente l’attività agricola (dal
1951 al 1981 l’agricoltura perdeva il 27,9% dei suoi addetti), il terziario
dell’impiego pubblico, del commercio al minuto e della vita di espedienti si
innalzava e si allargava come un “fungo” atomico (dal 30,3% del 1951 al 53,9%
del 1981).
La città si de-urbanizzava con un decremento
di popolazione residente del 4,9% tra il 1971 e il 1981, passando nel decennio
dai 400.048 abitanti ai 380.328).
Negli
anni di cui tratta Lazzaro Danzuso, tutto il comparto delle attività legate
all’acqua, al gas, alle industrie estrattive, a quelle manifatturiere per la
trasformazione dei metalli e per la meccanica di precisione beneficiò
dell’incremento irrisorio di 371 unità (ma la si continuava a chiamare,
Catania, la Milano del Sud). Era il settore delle
costruzioni(comprese le industrie di installazione degli impianti di edilizia)
a fare un ragguardevole balzo in avanti raggiungendo la quota di 2.665 unità che erano 911 nel 1971.
Mentre
a Torino comandava Agnelli, a Catania - ricorda Lazzaro Danzuso - la politica
della città che era cronaca giudiziaria sceglieva ad interlocutori privilegiati
gli astri autoctoni dell’imprenditoria: Ferrini, Massimino e i quattro
cavalieri dell’Apocalisse.
La
città, odiata-amata da Giuseppe Fava, si preparava ad essere rappresentata
spietatamente dai romanzi (romanzi?) di Silvana La Spina , Enzo Russo, Alfio
Caruso, di Antonio Di Grado. La città si preparava ad accogliere il viaggiatore
apocalittico Ceronetti per fargli scrivere che “a Catania non c’è di bello che
quel che è in sfacelo […]. Questo era un popolo fatto dalla povertà, nato per
essere povero; il denaro l’ha fritto come in un’enorme padella, e oggi la sua
faccia è annerita, ustionata”.
Non
ci capivamo niente: a Catania la delinquenza ubiquitaria dei quartieri stava
trovando il suo posto di eccellenza nella mafia. Uno l’aveva capito, ma noi non
avevamo capito che Giuseppe Fava l’aveva capito. Ci pareva fosse una trovata
teatrale (Catania è una città teatrale diceva Sciascia, dice Lazzaro Danzuso,
diciamo noi che mai la prendemmo, la prenderemo sul serio), un’esagerazione da
cui distogliere attenzione ed energie, indirizzate, invece, nei laboratori
rivoluzionari. Che fossero mafiosi i nostri imprenditori, non lo si voleva
riconoscere perché ciò avrebbe
ridimensionato l’impegno dell’apocalisse rivoluzionaria a solletico riformista,
a predica morale: per noi il capitalismo era intrinsecamente violento, a
Milano, felpatamente morbido, a Catania spudoratamente mafioso. Insomma, la
mafia era un aggettivo del sostantivo “padrone”. E noi eravamo ragazzi di
sostanza, sostanzialisti.
Non
ci capivamo niente, ma Catania non ci piaceva. Non ci piacevano i suoi
giornalisti, non leggevamo la stampa locale ed aspettavamo, come gli Ebrei il
Messia giustiziere, l’uscita di “Giovane Critica” o l’arrivo dei “Quaderni
Piacentini”.
Il
libro di Giuseppe Lazzaro Danzuso ci fa capire le ragioni di quel disagio
generazionale ed antropologico che subivamo e che non capivamo.
Un
libro coraggioso: ci vuole coraggio ad iniziare il racconto di una città amata
(grottescamente, ironicamente amata) con le imprese di Pippo Pernacchia o Pippu d’e pirita, uno che “si guadagnò
da vivere per cinquant’anni praticando,
da vero virtuoso, lo sberleffo sonoro”. Pippo Sapienza come Julien Sorel
de Il rosso e il nero di Henri Beyle: quello sberleffava a pagamento la
città, questo leggeva contro la sua
città, contro la sua famiglia. Non lo
capivamo, ma Pippo era tutti noi, i contestatori che sognavano l’altrove,
Parigi (o Londra).
L’autunno
“caldo” delle lotte operaie e studentesche si faceva inverno algido degli anni
di piombo, annunciato dall’uccisione dei braccianti di Avola del dicembre del
1968 e di due operai di Battipaglia nella primavera del 1969, esploso nel
dicembre del 1969 con una bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza
Fontana a Milano, e Giuseppe Pinelli cadde dalla finestra e, poi,
all’anniversario, come una celebrazione di ricorrenza, il principe Junio
Valerio Borghese tentò il colpo di Stato (ridicolo perché abortito) e Giovanni
Leone, superstizioso come una maschera della commedia italiana, avvocato di un
esponente della famiglia dei cavadduzzu in
un processo per omicidio, eletto nel 1971 Presidente degli Italiani,di tutti
gli Italiani, siciliani e il sottoscritto compresi, e Boia-chi- molla a Reggio di Calabria e Catania, dei sindaci
incolori Magrì e Marcoccio, divenne nera: nelle elezioni comunali del 1971 il
Movimento sociale Italiani ottenne un grande riconoscimento elettorale con il
21,5% dei voti.
Il prezzo del petrolio dei paesi dell’Opec
nell’autunno del 1973 giunse alle stelle, svalutando ulteriormente la lira, in
balia dei cambi instabili seguiti all’abbandono (agosto1971) del gold exchange standard degli accordi di
Bretton Woods del 1944 (la convertibiltà del dollaro in oro): giungeva al
termine la ricreazione del lungo quarto di secolo dalla conclusione della
seconda guerra mondiale.
La stagflazione si aggirava per l’economia
dell’Occidente: un matrimonio di sposi solitamente incompatibili, inflazione di
prezzi con aumento della circolazione monetaria ( con il contributo locale
dell’invenzione dei miniassegni di Pippo Recca, rammenta Lazzaro Danzuso) e
stagnazione di produzione e reddito.
“Nixon
boia”, tra Vietnam e Watergate, erano nel frattempo nate le Brigate rosse, era
nato il Gap di Giangiacomo Feltrinelli, e si rapiva il giudice di Genova Mario
Sossi. Una bomba a Brescia in piazza della Loggia (otto morti) e fu guerra
civile tra i giovani. Gli adulti, i democristiani compagni di partito di Leone,
Rumor e Gui, il socialdemocratico Tanassi prendevano tangenti dalla compagnia
aerospaziale, Lockheed. E si sparava, senza misericordia e a bersaglio, alle
gambe, al cuore, in testa a Montanelli, a Carlo Casalegno, a Walter Tobagi, a
magistrati, a poliziotti, ad operai, a professori universitari, a studenti, a
povera gente, ad Aldo Moro.
Come
si poteva amare il paese di Giovanni Leone, quello delle corna apotropaiche, delle
Brigate rosse e del terrorismo rosso e nero (solo cromaticamente stendhaliano)?
E
chi poteva avere testa alla mafia di Catania? Solo uno: Giuseppe Fava che amava
ed odiava Catania. Noi avremmo voluto essere (ed eravamo) altrove. Come
Sciascia, maestro di stendhalismo, che, inaugurando i suoi romanzi (romanzi?) di mafia con Il giorno della civetta
(1961, rappresentato nel 1964 da Giancarlo Sbragia allo Stabile di Catania),
“insegnando” (e trasfigurando in fantasma letterario) la mafia, in irriducibile
opposizione aveva caparbiamente testa al “compromesso storico” tra Sinistra e
“masse cattoliche che non esistono”, tra l’esistente (caspita, se esistente!)
Andreotti e Berlinguer, nel cui partito alle comunali palermitane del 1975 il
grand’uomo di Racalmuto veniva eletto come indipendente.
Noi
eravamo di casa, a due passi da casa, nella guerra dello “Yom Kippur”,
dell’attacco militare egiziano ad Israele (ottobre 1973), nella guerra civile
tra musulmani, palestinesi e cristiani maroniti del Libano, disputato da Siria
ed Israele.
Noi eravamo lontani dalla mafia e da casa;
eravamo di casa in quella schifezza feroce del cambogiano Pol Pot, nel Cile del
povero Allende e dell’abominevole Pinochet, nel Portogallo post-salazarista e
nella Spagna senza Francisco Franco.
Eravamo
in ogni luogo, tranne che a Catania. E conoscevamo Sarti, Burgnich, Facchetti e
Gigi Meroni. Sapevamo tutto dei Drusi, dei Falascià etiopi, dei Senussiti
libici, delle nazioni degli Indiani del Nord America, di Sartre e di Camus.
Non
ci restava tempo per informarci delle correnti democristiane nazionali, degli “ascari”
dei partiti romani.
Drago,
chi era Drago? E Micale? Di Turi Micale sapevamo quanto quel graffitaro
insospettato di Checco Rovella aveva pittato sui muri cittadini: “Il Pigno ha sete e Micale se ne fotte”.
Chi,
invece, era tutto a Catania di cui capiva gli umori profondamente superficiali,
popolari, quello fu Pippo Recca, il geniale pioniere a Catania della “terza
rivoluzione industriale” (televisione, informatica e telematica) che aveva
fatto i primi passi negli Usa degli anni Cinquanta e i secondi, di corsa, in
Giappone.
E
a questa città, alla sua città regalò lo specchio, fedelissimo specchio: la
televisione, “Teletna”.
Il
libro di Lazzaro Danzuso è un omaggio a Pippo Recca e, nel contempo, un
racconto stendhaliano (inconsapevole?) di questa nostra Grenoble, passata,
prossima e ventura.
“La gioia che dà Stendhal è imprevedibile quanto la vita, quanto le ore
di una giornata e quanto le giornate di una vita. Quando e quanto più crediamo
di conoscerlo, ecco che ci sorprendiamo a scoprirlo in un passo, in una frase;
o a sovvertire, tra i suoi libri, l’ordine delle preferenze, delle affezioni”
Testi di riferimento:
Guido
Ceronetti, Un viaggio in Italia, 1981-1983, Einaudi 1983
Franco Sidoti, Povertà,
devianza, criminalità nell’Italia meridionale, Franco Angeli 1989
Alfio Caruso, Tutto a posto
1991 e I penitenti, Mondadori
1993
Claudio Fava, La mafia comanda
a Catania (1960-1991), Laterza 1991
Antonio Di Grado, Casa la Gloria , Il Girasole
1992
Enzo Russo, Nato in Sicilia,
Mondadori 1992
Silvana La Spina , L’ultimo treno da
Catania, Bompiani 1992
Tino Vittorio, L’ordine e la moralità negli affari a Catania, Collegio de Ragionieri di Catania 1993
Fabio Albanese, La tele
dell’Etna, Bonanno 2007
Nessun commento:
Posta un commento