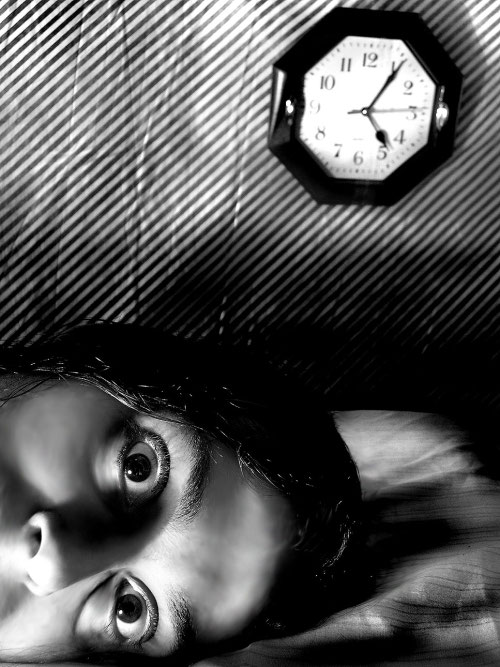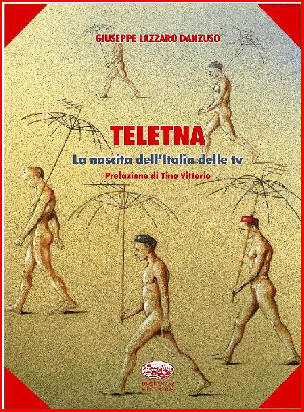È possibile essere comunisti senza Marx?
di ANTONIO NEGRI
È possibile essere comunisti senza Marx? È evidente che sì. Ciò non toglie che mi capiti spesso di discuterne con compagni e con intellettuali sovversivi di differenti estrazioni. Soprattutto in Francia – e le considerazioni che seguono riguardano essenzialmente la Francia. Debbo comunque confessare che spesso mi annoio a ragionare su questi argomenti, ci son linee troppo diverse e contraddizioni che raramente son condotte a confrontarsi con verifiche o soluzioni sperimentali. Si tratta spesso di confrontarsi con retoriche che astrattamente affrontano la pratica politica. E tuttavia, talora, ci si scontra con posizioni che negano addirittura che ci si possa dichiarare comunisti se si è marxisti. Da ultimo, ad esempio, un importante studioso – che pure aveva sviluppato nel passato le ipotesi del “maoismo” più radicale – mi diceva che, se ci si attenesse al marxismo rivoluzionario, che prevedeva il “deperimento dello Stato”, la sua “estinzione”, dopo la conquista proletaria del potere, e certo non ha realizzato questa finalità, non ci si potrebbe più dichiarare “comunisti”. Obiettavo che è come dire che il cristianesimo è falso perché il Giudizio Universale non è arrivato nei tempi prossimi, previsti dall’Apocalisse di Giovanni, e la “resurrezione dei morti” non la si è proprio vista! Ed aggiungevo che nell’epoca del disincantamento, la fine del secolo mondano per i cristiani e la crisi della escatologia socialista equivocamente sembrano giacere sotto la stessa coperta, meglio, subire eguali ingiunzioni epistemologiche – però, del tutto fallaci. È certo infatti che il cristianesimo è falso – ma io credo che lo sia per tutt’altre ragioni. E se anche il comunismo è falso, non lo è certo perché la speranza escatologica non si è in questo caso realizzata: non dico infatti che essa non fosse infatti implicita nella premessa, ma solo che molte delle “profezie” (meglio, dei dispositivi teorici) del comunismo marxiano si sono realizzate, al punto che oggi è ancora impossibile – senza Marx – affrontare il problema della lotta contro lo schiavitù del capitale. Proprio per questo, probabilmente, sarebbe importante ritornare dal cristianesimo a Cristo e dal comunismo a Marx…
E allora? Non si è data l’estinzione dello Stato, in Russia e in Cina lo Stato è divenuto onnipotente ed il comune è stato organizzato (e falsificato) nelle forme del pubblico: lo statalismo ha quindi vinto e, sotto quest’egemonia, non il comune ma un capitalismo burocratico sommamente centralizzato si è imposto. Tuttavia a me sembra che attraverso le grandi esperienze rivoluzionarie comuniste del secolo ventesimo, l’idea di una “democrazia assoluta”, e di un “comune degli uomini”, sia stata dimostrata possibile. Ed intendo la “democrazia assoluta” come un progetto politico che si costruisce oltre la democrazia “relativa” dello Stato liberale, e dunque come l’indice di una radicale rivoluzione contro lo Stato, di una pratica di resistenza e di costruzione del “comune” contro il “pubblico”, del rifiuto dell’esistente e dell’esercizio della potenza costituente da parte della classe dei lavoratori sfruttati.
Qui interviene la differenza. Qualunque sia stata la conclusione, il comunismo (quello che si è mosso secondo l’ipotesi marxista) si è provato (anche senza realizzarsi) attraverso un insieme di pratiche che non sono solo aleatorie, non solo transitorie: si è trattato di pratiche ontologiche. La questione, dunque, se si possa esser comunisti senza essere marxisti, dovrebbe prima di tutto confrontarsi con la dimensione ontologica del comunismo, con la determinazione materialista di questa ontologia, con i suoi residui effettivi, con l’irreversibilità di quel episodio nella realtà e nel desiderio collettivo degli uomini. Il comunismo è una costruzione, ci ha appreso Marx, un’ontologia, cioè la costruzione di una nuova società da parte dell’uomo produttore, del lavoratore collettivo, attraverso un agire che si rivela efficace perché è diretto all’accrescimento dell’essere.
Questo processo si è aleatoriamente dato, quest’esperienza si è parzialmente realizzata. Il fatto che sia stata sconfitta, non dimostra che sia impossibile: anzi è effettualmente mostrato che essa è possibile. Molti milioni di uomini e di donne hanno operato e pensato, lavorato e vissuto dentro questa possibilità. Nessuno nega che l’epoca del “socialismo reale” abbia ceduto a, e sia stata attraversata da, orribili derive. Ma sono esse tali da avere determinato un annullamento di quell’esperienza, da aver tolto quell’accrescimento dell’essere che il realizzarsi del possibile e la potenza dell’evento rivoluzionario avevano costruito? Se ciò fosse avvenuto, se il negativo che ha pur pesantemente intaccato la vicenda del “socialismo reale”, avesse prodotto una prevalente distruzione dell’essere, l’esperienza del comunismo sarebbe scivolata via e si sarebbe dispersa nel nulla. Ma questo non è avvenuto. Il progetto di una “democrazia assoluta”, l’istanza di costruire il “comune degli uomini” restano attrattivi, intatti nel nostro desiderio e nella nostra volontà. Non dimostra forse questa permanenza, questo materialismo del desiderio, la validità del pensiero di Marx? Non è perciò difficile, se non impossibile, essere comunisti senza Marx?
All’obiezione sullo statalismo che “necessariamente” deriverebbe dalle pratiche marxiste, occorre dunque rispondere riarticolando la nostra analisi: assumendo cioè che l’accumulazione dell’essere, il progredire della “democrazia assoluta”, l’affermazione della libertà e dell’uguaglianza, passano attraverso e subiscono incessantemente soste, interruzioni, catastrofi – ma che quest’accumulazione è più forte dei momenti distruttivi che pur conosce. Questo processo infatti non è finalistico, teleologico e neppure è una mossa di filosofia della storia: non lo è perché quest’accumulazione di essere che pur vive attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l’intersezione di mille e mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti. Quella storia, quest’accumulazione sono prodotti delle singolarità concrete (che la storia ci mostra in azione) e produzioni di soggettività. Noi le assumiamo e le descriviamo a posteriori. Non c’è nulla di necessario, tutto è contingente ma concluso, tutto è aleatorio ma compiuto, nella storia che raccontiamo. Nihil factum infectum fieri potest: c’è forse filosofia della storia laddove i viventi desiderano solo continuare a vivere e per ciò esprimono dal basso una teleologia intenzionale della vita? La “volontà di vivere” non risolve i problemi e le difficoltà del vivere ma ci si presente nel desiderio come urgenza e potenza di costituzione del mondo. Se vi sono discontinuità e rotture, esse si rivelano nella continuità storica – una continuità sempre frastagliata, mai progressiva – ma neppure globalmente, ontologicamente catastrofica. L’essere non può mai essere totalmente distrutto.
Altro tema: quell’accumulazione di essere costruisce del comune. Il comune non è una finalità necessaria – è bensì un aumento dell’essere perché l’uomo desidera essere molteplicità, stabilire relazioni, essere moltitudine – non potendo star da solo, soffrendo soprattutto la solitudine. In secondo luogo, quell’accumulazione di essere non sarà neppure identità né origine: è essa stessa un prodotto di diversità e di consensi/contrasti fra singolarità, articolazione di costruzioni linguistiche e di determinazioni storiche, frutto di incontri e scontri. Va qui soprattutto sottolineato che il comune non si presenta come l’universale. Può contenerlo ed esprimerlo, ma non vi si riduce, è più esteso e temporalmente dinamico. L’universale si può predicare di ogni e di tutti gli individui. Ma il concetto di individuo autosussistente è contraddittorio. Non c’è individualità ma solo relazione di singolarità. Il comune ricompone l’insieme delle singolarità. Questa differenza del comune dall’universale è qui assolutamente centrale: Spinoza la definì quando, alla generica vuotezza dell’universale e all’inconsistenza dell’individuo, oppose la concreta determinazione delle “nozioni comuni”. Universale è ciò che nell’isolamento, nella solitudine, ogni soggetto può pensare; comune è invece quello che ogni singolarità può costruire, costituire ontologicamente a partire dal fatto che ogni singolarità è molteplice ma determinata concretamente nella molteplicità, nella comune relazione. L’universale è detto del molteplice, mentre il comune è determinato, è costruito attraverso il molteplice e qui specificato. L’universalità considera il comune come un astratto e lo immobilizza nel corso storico: il comune sottrae l’universale all’immobilità e alla ripetizione. E lo costruisce invece concretamente.
Ma tutto questo presuppone l’ontologia. Ecco dunque dove il comunismo ha bisogno di Marx: per impiantarsi nel comune, nell’ontologia. E viceversa. Senza ontologia storica non c’è comunismo.
Si può essere comunisti senza essere marxisti? Diversamente dal “maoismo” francese, che non ha mai frequentato Marx (ma su questo ritorneremo), Deleuze e Guattari ad esempio furono comunisti senza essere marxisti, ma lo furono in maniera estremamente efficace, fino al punto che si favoleggiò di un Deleuze autore, in punctuo mortis, di un libro intitolato “La grandeur di Marx”. Deleuze e Guattari costruiscono il comune attraverso degli agencements collectifs e un materialismo metodologico che li avvicina al marxismo ma li tiene distanti dal socialismo classico, e comunque da ogni ideale organico di socialismo e/o statalistico di comunismo. Sicuramente Deleuze e Guattari si dichiararono tuttavia comunisti. Perché? Perché, senza essere marxisti, furono implicati in quei movimenti di pensiero che si aprivano continuamente alla pratica, alla militanza comuniste. In particolare, il loro materialismo fu ontologico, il loro comunismo si sviluppò sui mille plateaux della pratica trasformativa. Mancava loro la storia, quella positiva che certo spesso può aiutare nel produrre e nel comprendere la dinamica della soggettività (in Foucault, questo dispositivo è finalmente reintegrato nell’ontologia critica): talora tuttavia la storiografia positivista, certo, ma talora la storia può essere iscritta all’interno della metodologia materialista, senza quegli orpelli cronologici e quell’eccessiva insistenza sugli eventi, tipica di ogni Historismus – e appunto ciò che avviene in Deleuze-Guattari. Insisto sulla complementarietà di materialismo e ontologia perché la storia (che nella prospettiva tanto dell’idealismo classico quanto del positivismo era certo ricalcata dalla filosofia, ma per finalizzarla ad ipostasi politiche o etiche e così a negarne la dimensione ontologica) può, invece, essere talora tacitamente ma efficacemente sussunta – quando l’ontologia costituisca dispositivi particolarmente forti, come avveniva in Deleuze-Guattari. Non bisogna infatti dimenticare che il marxismo non vive solo nella scienza ma piuttosto si svolge dentro esperienze “situate”: il marxismo è spesso rivelato dai dispositivi militanti.
Diversamente van le cose quando, ad esempio, si confronti il nostro problema (comunismo/marxismo, storia/ontologia) alle numerose varianti del socialismo utopistico, soprattutto a quello di derivazione “maoista”. Nell’esperienza francese del “maoismo” si assistette al diffondersi di una specie di “odio per la storia”, che – qui consistete la sua spaventosa deficienza – rivelava un estremo disagio quando si trattasse di produrre obiettivi politici. Così, infatti, evacuando la storia, si evacuava non solo il marxismo ma anche la politica. Paradossalmente si ripeteva, nella direzione opposta, quello che era avvenuto in Francia nel periodo della fondazione della scuola degli “Annales” di Marc Bloch e di Lucien Febvre: in quell’occasione il marxismo venne introdotto nella discussione filosofica attraverso la storiografia. E la storiografia divenne politica!
Altrettanto vale per il socialismo utopistico: si deve riconoscere che, in talune delle sue esperienze (fuori dalle varianti maoiste), esso ha offerto connessioni materialiste di ontologia e storia – non sempre, ma sovente. Si pensi solo – per quel che riguarda l’esperienza francese – ai formidabili contributi di Henri Lefebvre. Si tratterà allora di comprendere se e fino a che punto, dentro questo variare di posizioni diverse, emergono talora posizioni che (in nome dell’universalità del progetto politico proposto) si oppongono alla praxis ontologica – negando, ad esempio, la storicità di categorie come l’“accumulazione originaria” e proponendo di conseguenza l’ipotesi di un comunismo come pura restaurazione, immediata, dei commons, oppure svalutando le metamorfosi produttive che configurano variamente la “composizione tecnica” della forza lavoro (che è vera e propria produzione materialista di soggettività nella relazione fra rapporti produttivi e forze produttive), riconducendo in maniera radicale alla natura umana (sempre uguale,sub forma arithmeticae) l’origine della protesta comunista, ecc. ecc.: si tratta evidentemente di una riedizione ambigua dell’idealismo nella sua figura trascendentale.
Per esempio: in Jacques Rancière abbiamo recentemente visto accentuarsi i dispositivi che negano ogni connessione ontologica di materialismo storico e comunismo. La prospettiva dell’emancipazione del lavoro si sviluppa infatti, nella sua ricerca, in termini di autenticità della coscienza, assumendosi conseguentemente la soggettività in termini individuali, e quindi togliendo di mezzo – proprio prima di cominciare – ogni possibilità di chiamarecomune la produzione di soggettività. Inoltre l’azione emancipatrice si stacca qui da ogni determinazione storica e proclama la sua indipendenza dalla temporalità concreta: la politica, per Rancière, è un’azione paradossale che stacca il soggetto dalla storia, dalla società, dalle istituzioni, pur quando, senza quella partecipazione (quell’inerenza che può essere radicalmente contraddittoria), il soggetto politico non sarebbe neppure predicabile. Il movimento di emancipazione, la “politica” perdono così ogni caratteristica di antagonismo, non in astratto ma sul terreno concreto delle lotte, e le determinazioni dello sfruttamento non si vedono più e (parallelamente) non costituisce più problema l’accumulazione del potere nemico, della “polizia” (sempre presentata in una figura indeterminata, non quantitate signata). Quando il discorso di emancipazione non riposa sull’ontologia, diviene utopia, sogno individuale e lascia il tempo che trova.
Siamo così entrati in medias res, al punto di chiederci se (dopo il sessantotto) ci sia mai stato un comunismo collegato al marxismo in Francia. C’è stato certamente (e permane) nelle due varianti dello stalinismo e del trotzkismo, l’una e l’altra ormai partecipanti di una storia lontana ed esoterica. Quando invece si viene alla filosofia del ’68, qui il rifiuto del marxismo è radicale. Vogliamo riferirci essenzialmente alle posizioni di Badiou, che godono di una certa popolarità.
Una breve precisazione. Quando Rancière, nelle immediate adiacenze del ’68, sviluppava (dopo aver partecipato alla comune lettura de “Il Capitale”) una critica pesante delle posizioni di Althusser, e metteva in luce come nella critica dell’umanesimo marxista (che solo dopo il ’68 – con un certo ritardo, dunque! – si apriva in Althusser alla critica dello stalinismo) permanessero in realtà gli stessi presupposti intellettualisti dell’“uomo di partito” e l’astrazione strutturalista del “processo senza soggetto” – aveva ragione da vendere. Ma non si dovrebbe oggi, da parte di Rancière sollevare la stessa critica nei confronti di Badiou? Anche per Badiou infatti è solo l’indipendenza della ragione, la sua garanzia di verità, la sistematicità di un’autonomia ideologica – è solo a queste condizioni che si determina la definizione del comunismo. “N’est-ce pas, sous l’apparance du multiple, le retour à une vieille conception de la philosophie supérieure?” – si chiedono Deleuze-Guattari. È quindi molto difficile capire dove stiano per Badiou le condizioni ontologiche del soggetto e della rottura rivoluzionaria. Per lui, infatti ogni movimento di massa costituisce una performance piccolo borghese, ogni lotta immediata, del lavoro materiale o cognitivo, di classe o del “lavoro sociale”, è qualcosa che mai toccherà la sostanza del potere – ogni allargamento della capacità collettiva di produzione dei soggetti proletari non sarà altro che un allargamento del loro assoggettamento alla logica del sistema – quindi, l’oggetto è inarrivabile, il soggetto indefinibile, a meno che la teoria non lo produca, a meno di disciplinarlo, di adeguarlo alla verità e di innalzarlo all’evento – oltre la pratica politica, oltre la storia. Ma tutto questo è ancor poco rispetto a quello che ci aspetta se seguiamo il pensiero di Badiou: ogni quadro di lotta, specificamente determinato, gli sembra (se la teoria e l’esperienza militante gli attribuiscono una potenza di sovversione) solo un’allucinazione onirica. Insistere ad esempio sul “potere costituente” sarebbe per lui sognare la trasformazione di un immaginario “diritto naturale” in una potenza politica rivoluzionaria. Solo un “evento” può salvarci: un evento che sia fuori da ogni esistenza soggettiva che sappia determinarlo e da ogni pragmatica strategica che ne rappresenti il dispositivo. L’evento per Badiou (la crocifissione di Cristo e la sua resurrezione, la Rivoluzione francese, la Rivoluzione culturale cinese, ecc.) è sempre definito a posteriori, è dunque un presupposto e non un prodotto della storia. Di conseguenza, paradossalmente, l’evento rivoluzionario esiste senza Gesù, senza Robespierre, senza Mao. Ma, privato di una logica interna di produzione dell’evento, come si potrà mai distinguere l’evento da un oggetto di fede? Badiou, in realtà, si limita con ciò a ripetere l’affermazione mistica, normalmente attribuito a Tertulliano: “credo quia absurdum” – credo, cioè, perché è assurdo. Qui l’ontologia viene spazzata via. Ed il ragionamento comunista è ridotto o a un colpo di matto o a un business dello spirito. Per dirla tutta, ripetendo Deleuze-Guattari: “l’événement lui-même apparaît (selon Badiou), moins comme une singolarità que comme un point aléatoire séparé qui s’ajout ou se soustrait au site, dans la trascendance du vide ou la vérité comme vide, sans qu’on puisse décider de l’appartenance de l’événement à la situation dans laquelle se trouve son site (l’indécidable). Peut-être en revanche y a-t-il une intervention comme un jet de dé sur le site qui qualifie l’événement et le fait entrer dans la situation, une puissance de « faire » l’événement”.
Ora, si comprendono facilmente alcuni dei presupposti di queste posizioni teoretiche (che comunque partono da una sofferta e condivisa autocritica di pratiche rivoluzionarie trascorse). Si trattava, infatti, in primo luogo, di distruggere ogni riferimento alla storia di un “socialismo reale”, sconfitto, sì, ma sempre e comunque infarcito di premesse dogmatiche e di un’organica disposizione al tradimento. In secondo luogo, si voleva evitare di stabilire qualsiasi relazione fra le dinamiche dei movimenti sovversivi e i contenuti e le istituzioni dello sviluppo capitalistico. Giocare con questi, dentro/contro, come la tradizione sindacale proponeva, aveva infatti prodotto corruzione del desiderio rivoluzionario ed illusione delle volontà in lotta. Ma trarre da questi giusti obiettivi critici la conseguenza che ogni tentativo politico, tattico e strategico di ricostruzione di una pratica comunista e la fatica di questo esercizio, siano esclusi dalla prospettiva di liberazione; che non possa darsi un progetto costituente, né alcuna presa trasformativa dentro la dimensione materiale, immediatamente antagonista delle lotte; e che ogni tentativo di render conto delle forme attuali del dominio, in qualsiasi modo esso si sviluppi, sia comunque subordinato ed assorbito dal comando capitalistico; che infine ogni riferimento alle lotte all’interno di un tessuto biopolitico, a lotte – dunque – che considerino in una prospettiva materialistica le articolazioni del Welfare, non rappresentino altro che un rigurgito vitalista – bene, tutto questo ha un solo significato: la negazione della lotta di classe. E ancora: secondo l’“estremismo” badiousiano, il progetto del comunismo non può darsi se non in maniera privativa e dentro forme di sottrazione dal potere, e la nuova comunità non potrà che essere il prodotto dei senza comunità (come d’altra parte sostiene Rancière). Quello che offende, in questo progetto, è la purezza giansenista che esso esibisce: ma quando le forme dell’intelligenza collettiva sono a tal punto disprezzate – perché ogni forma d’intelligenza prodotta nella storia concreta degli uomini è ricondotta alla logica del sistema di produzione capitalista – allora, non c’è più niente da fare. O, meglio, resta da riaffermare l’osservazione sopra già fatta, e cioè che la pragmatica materialista (quella che abbiamo conosciuto fra Machiavelli e Nietzsche, fra Spinoza e Deleuze), quel movimento che vale esclusivamente per sé stesso, quel lavoro che rinvia solo alla propria potenza, quell’immanenza che si concentra sull’azione e sull’atto di produzione di essere – è in ogni caso più comunista di ogni altra utopia che abbia un rapporto schizzinoso con la storia ed incertezze formali con l’ontologia.
Noi non crediamo dunque possibile parlare di comunismo senza Marx. Certo, il marxismo va profondamente, radicalmente riletto e rinnovato. Ma anche questa trasformazione creativa del materialismo storico può avvenire seguendo le indicazioni di Marx – arricchendolo con quelle che derivano dalle correnti “alternative” vissute nella modernità, da Machiavelli a Spinoza, da Nietzsche a Deleuze-Foucault. E se Marx studiava le leggi di movimento della società capitalista, ora si tratta di studiare le leggi del lavoro operaio, meglio, dell’attività sociale tutta intera, e della produzione di soggettività dentro la sussunzione della società nel capitale e l’immanenza della resistenza allo sfruttamento sull’orizzonte globale. Oggi non basta più studiare le leggi del capitale, bisogna lavorare all’espressione della potenza della ribellione dei lavoratori ovunque. Sempre seguendo Marx: quello che ci interessa “è il lavoro non come oggetto ma come attività; non come valore esso stesso ma come sorgente viva del valore. Di fronte al capitale, nel quale la ricchezza generale esiste oggettivamente, come realtà, il lavoro è la ricchezza generale come sua possibilità, che si conferma nell’attività come tale. Non è affatto una contraddizione dunque affermare che il lavoro è, per un lato, la miseria assoluta come oggetto, per l’altro è la possibilità generale della ricchezza come soggetto e come attività”. Ma come cogliere il lavoro in questo modo, e cioè non come oggetto sociologico ma come soggetto politico? Questo è il problema, questo è l’oggetto dell’inchiesta. Solo risolvendo questo problema possiamo parlare di comunismo – se è necessario (e quasi sempre lo è) sporcandoci le mani. Tutto il resto è chiacchiera intellettualista.